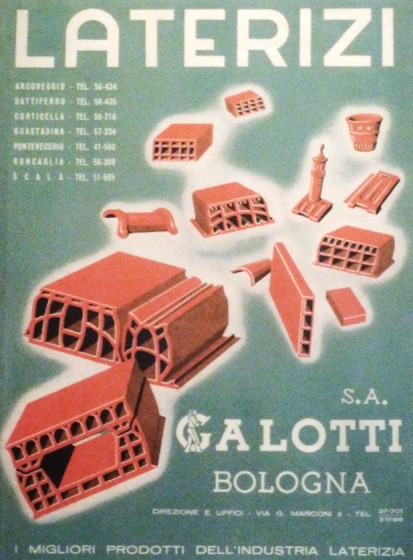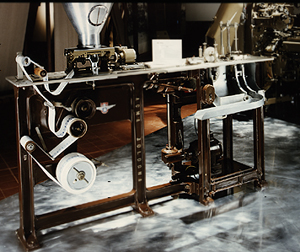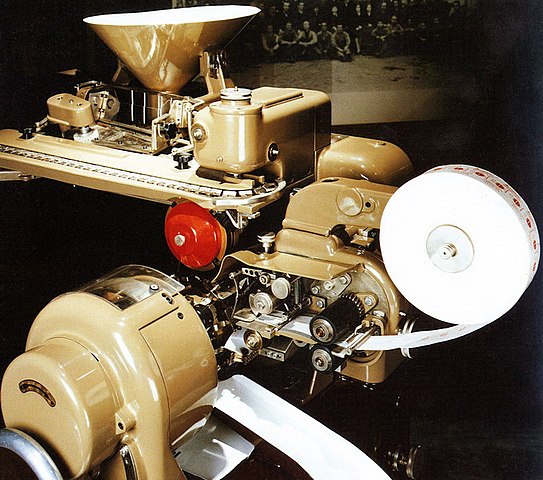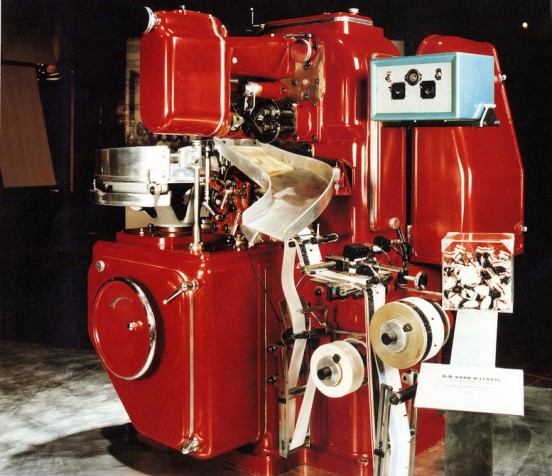| Il Forno Hoffmann |
| Il Portico di Accesso |
| La Produzione di Mattoni |
| Anni '80: L'acquisizione del Comune di Bologna |

| Introduzione |
| Il Mulino da Seta Bolognese |
| La Lavorazione della Seta |
| Il Modello del Mulino da Seta Bolognese |
| Il Sistema dei Canali Bolognesi |
| Il Canale Navile |
| Le Collezioni |
| Il Gabinetto Aldini di Fisica e Chimica Applicata |
| La Collezione Giovanni Aldini |
| Gli Istituti Aldini Valeriani |
| Le Scuole Tecniche Bolognesi |